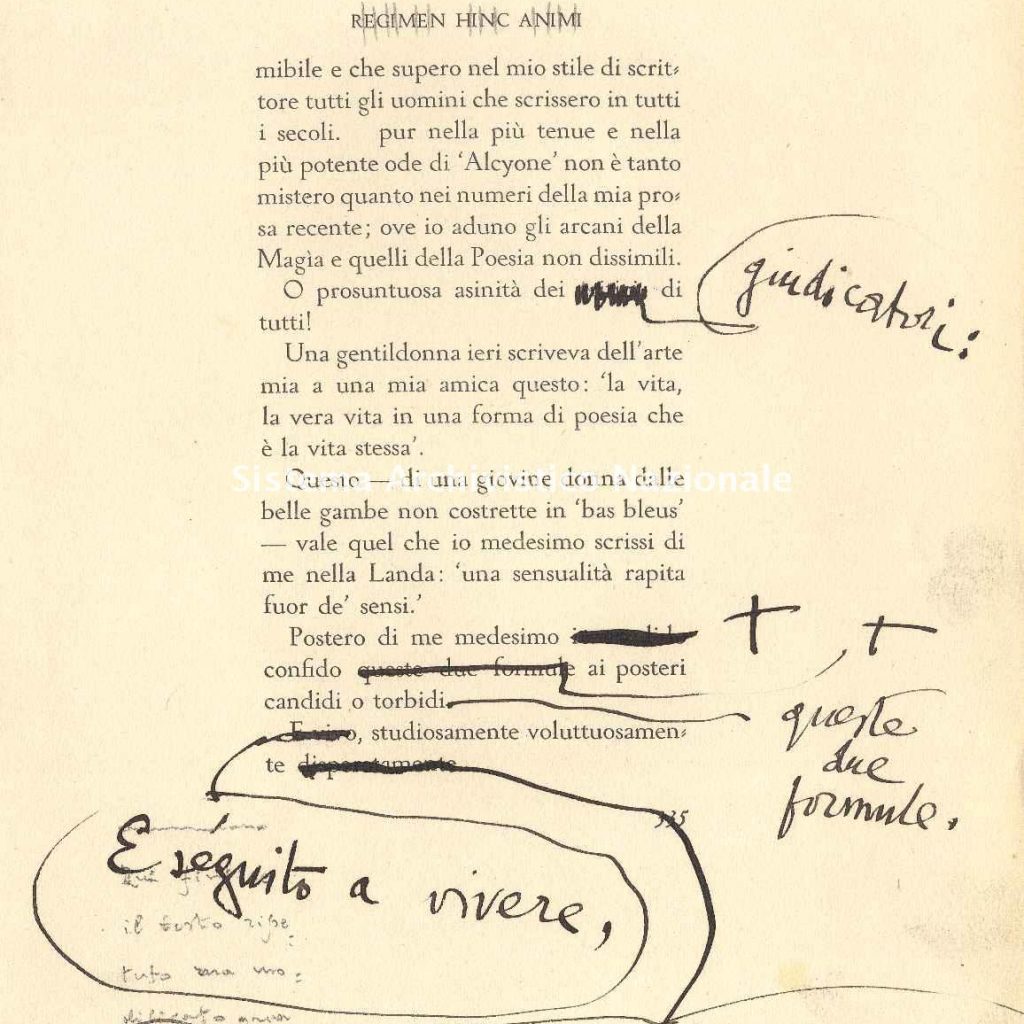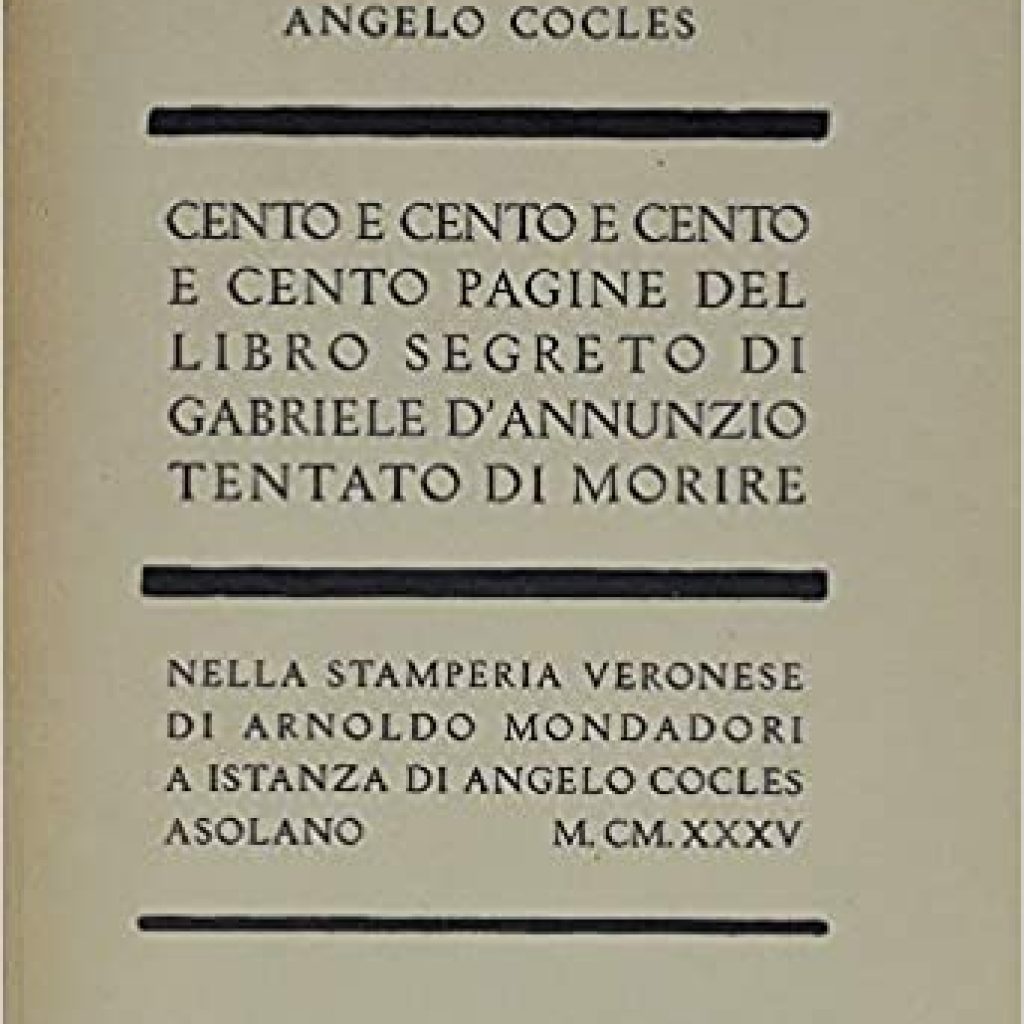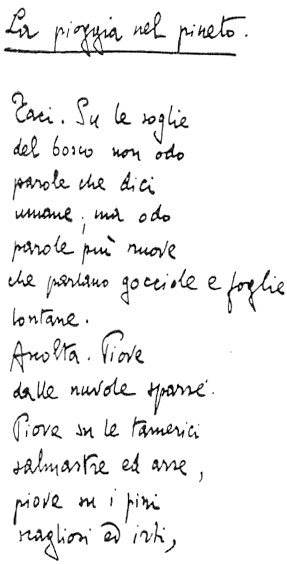una passeggiata sulle tracce di Parmenide
A Elea sono giunto passando per la Porta Rosa. Ho fatto la breve salita che conduce all’arco massiccio. L’ho attraversato, pensando che, forse, anche Parmenide – e chissà quante volte – ci era passato in mezzo e poi sono salito su, fino all’acropoli, al fortilizio di Castelluccio.



Il cielo era quello alto di aprile – un cielo languido e stinto – e dal Castelluccio, guardavo la costa sabbiosa e poi alta, verso nord, le case di vacanza tutte chiuse e spente, le spiagge vuote e il mare, azzurro e ancora opaco, per via della luce poco primaverile. Qui gli ulivi sono grandi e alti, da sembrare querce. Sono risceso, ripassando dalla Porta, sulla strada che ha duemilacinquecento anni e, facendo questa via, su queste pietre, ho avuto il privilegio – era il 2011 – di accompagnare Giovanni Reale. Maggiore sarebbe stato soltanto il privilegio di accompagnare Parmenide stesso, poeta-filosofo, o Zenone o Melisso, che di lui erano stati seguaci e discepoli.
Diogene Laerzio di Parmenide scriveva che era stato allievo di Senofane, ma questo probabilmente non fu, e che comunque non lo seguì. Scriveva che aveva riconosciuto quale maestro Aminia, il pitagorico, e che gli aveva fatto erigere a proprie spese una tomba che pareva un piccolo tempio, quando Aminia morì. Aminia era povero, ma era uomo eccellente. Parmenide (ca 540 a.C-450 a.C.), allora un giovane che si preparava a essere eccellente, era ricco, di «stirpe illustre». Si dedicò alla filosofia. «Per primo – affermava ancora Diogene – [Parmenide] dimostrò che la terra è sferica, che è situata nel centro, che esistono due principi, il fuoco e la terra, e che il primo ha funzione di demiurgo, la seconda di materia».
Empedocle l’agrigentino, di cui abbiamo già detto qualcosa, di Parmenide fu discepolo e successore (Suda) e, infatti, di Parmenide ritroviamo in Empedocle la teoria dei due principi, che Empedocle chiamava Neikos e Philia, Odio e Amore (17DK).
«Le cavalle che mi portano – scriveva Parmenide e la sua era poesia filosofica – secondo lo slancio della mia volontà, mi inviarono […] alla via dispensatrice di molte conoscenze». Sulla via della verità lo avevano condotto, tirandolo come su un cocchio, magiche cavalle. Il pensiero gli si era dischiuso davanti agli occhi: una porta apertasi «per le strade del Giorno e della Notte». Qui l’aveva accolto una dea. Gli diceva: «è necessario che tu apprenda tutto, tanto il cuore immobile della Verità rotonda, quanto le opinioni dei mortali, in cui non si trova verace certezza» (fr 1-2).
La verità è “rotonda”, per Parmenide, a forma di sfera, così come a forma di sfera è il mondo e l’essere. La dea gli dice che l’essere e il pensiero sono una stessa cosa; che «identico è il pensare e l’esistere» (fr 3). Ecco la verità. Se ci sia, qui dentro, l’idea che anche il mondo abbia forma di sfera è difficile dire con certezza, ma per la bellezza della sua scrittura e per il fascino e l’intuizione dei suoi frammenti, gli interpreti hanno visto nel pensiero di Parmenide un’incredibile e precoce profondità.
Parmenide, testimoniava di lui Plutarco, «ha raffigurato un sistema cosmico e mediante la mescolanza di luce e tenebra quali elementi, da questi e per mezzo di questi, rende ragione di tutti i fenomeni. Infatti ha trattato ampiamente della terra e del cielo e del sole e della luna e degli astri e ha esposto la generazione degli uomini».
Lo fece da lassù, guardando l’ampio orizzonte che oggi è di Ascea-Velia, dalla collina dell’acropoli, con il mare che sembra incurvarsi e il cielo che gli aderisce. [s.t. 22.5.2023]

—
Per questa e altre storie, visita www.stefanotermaninieditore.it
I nostri più recenti libri di poesia sono qui. Vieni a visitarci:
– Rita Parodi Pizzorno, Le Antiche Mura ([open access] https://bit.ly/3F92TaB )
– Paolo Castagnola, Tra le parole e il sale (https://bit.ly/3yRb0b0)
– Antonietta Bocciardo, Or si frange l’onda (https://bit.ly/AntoniettaBocciardo_orsifrangelonda)